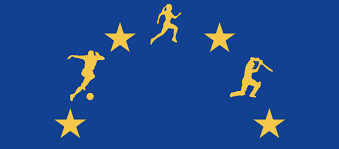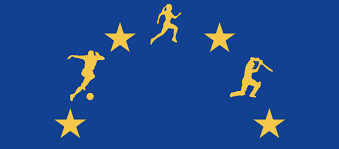Il tema dei rapporti tra lordinamento comunitario e lo sport è stato oggetto di varie questioni politiche, dottrinali e giurisprudenziali. A fondamento di tale interesse si rinvengono varie ragioni: la rilevanza economica dello sport, la necessità di tutela del diritto di libera circolazione dei lavoratori sportivi, lapplicazione della disciplina comunitaria della concorrenza, non solo alle trasmissioni televisive riguardanti le attività sportive, dunque gli eventuali diritti televisivi e ciò che ne deriva, ma anche ai concorsi relativi ai pronostici sportivi. Detto interesse, fino agli anni Ottanta era volto a garantire ladeguamento delle imprese e dei pubblici poteri al mercato unico, nonostante le due note sentenze (Walrave e Donà) della Corte di Giustizia Europea degli anni Settanta avessero sancito lassoggettibilità dellattività sportiva ai principi europei del mercato interno, nella misura in cui lattività sportiva veniva svolta sotto forma di attività economica. Le Istituzioni europee e quelle sportive vivevano, infatti, in una sorta di magico isolamento reciproco, senza alcuna particolare influenza e/o ingerenza delle prime sulle seconde. La Corte di Giustizia europea, intanto, cominciava a tracciare le linee guida che, poi, serviranno anche per i casi futuri. L′azione dei giudici si è occupata in primis della verifica dei confini dellazione europea in materia sportiva, in accordo col principio di competenze di attribuzione, dal momento che lo sport all′epoca era ancora lontano dall′essere incluso nelle agende comunitarie. Nello specifico, la Corte ha stabilito che l′attività sportiva è disciplinata solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dellarticolo 2 TCEE (oggi articolo 3 TUE). Dagli anni Novanta in poi, le iniziative adottaste dalla Comunità europea sono state improntate ad un diverso disegno, che ha posto in primo piano la dimensione sociale dello sport. Allinizio degli anni Novanta, infatti, la Commissione europea adottava la Comunicazione su La Comunità europea e lo sport; nel successivo 1992 a Rodi, venivano approvati dalla Conferenza dei Ministri europei dello sport: la Carta europea dello sport, con cui, tra i vari scopi, enunciava limpegno delle istituzioni comunitarie a garantire ad ogni individuo la possibilità di praticare lo sport ed il Codice europeo di etica sportiva, che riconosceva il valore della morale etica sportiva. Questultimo, enuncia il fair play quale elemento essenziale di ogni attività sportiva, come testualmente citato: fair play-il modo vincente, chi gioca lealmente è sempre vincitore. Si assiste, dunque, ad un cambiamento di indirizzo delle politiche comunitarie in materia sportiva, confermato dalle ulteriori iniziative promosse negli anni successivi, come ad esempio la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam del 1997, ove viene evidenziata la rilevanza sociale dello sport e vengono invitati gli organi dellUE a uniformarsi e a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. Va poi richiamata, in tal senso, la Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo nellottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario (c.d. Relazione di Helsinki). Si ribadisce ancora una volta la funzione educativa e sociale dello sport, limportanza dellinsegnamento delleducazione fisica nelle scuole e limpatto positivo dello sport sulla salute. Si evidenzia inoltre la necessità di assicurare lautonomia delle istituzioni sportive nazionale ed internazionale per quanto concerne lamministrazione e lorganizzazione delle rispettive discipline sportive, con linvito alle federazioni a rafforzare la democrazia interna. Dunque, dal 1995 sino al 2005 la Corte di Giustizia, riprendendo la propria giurisprudenza degli anni Settanta, ribadisce i seguenti tre principi fondamentali: a) lattività sportiva, se ed in quanto costituisce unattività economica, è assoggettata ai principi del diritto dellUnione europea; b) tuttavia, in considerazione delle caratteristiche specifiche dello sport, si deve ritenere che le norme emanate dalle federazioni sportive dettate da motivi puramente tecnici e che non hanno nulla a che fare con lattività economica (c.d. regole puramente sportive) siano sottratte allambito di applicazione del diritto dellUnione europea; c) rientrano tra le regole puramente sportive le regole del gioco (ad es. regole che fissano la lunghezza delle partite o il numero di giocatori sul campo), le norme relative ai criteri di selezione per le competizioni sportive, quelle sulla composizione delle squadre nazionali e quelle sul doping. Tale impostazione concettuale, peraltro, non stava ad indicare che tutte le regole non qualificabili come puramente sportive dovevano essere ritenute, se effettivamente in grado di limitare o restringere una libertà fondamentale, inevitabilmente contrarie al diritto europeo. Anche tali regole, infatti, potevano ritenersi comunque compatibili con il diritto europeo se, nonostante gli effetti restrittivi, fossero state giustificate in considerazione degli obiettivi legittimi perseguiti, della loro idoneità a raggiungerli e dal carattere proporzionato della misura rispetto agli stessi. Con riguardo, per lappunto, allidentificazione delle regole sportive (o regole non economiche) che esulano dal campo dapplicazione della legislazione UE, la Corte europea e la Commissione europea hanno deciso che tale questione va risolta caso per caso. E, a tal proposito, significativa la pronuncia della Corte di Giustizia europea, nel caso Deliège, che ha riconosciuto che le regole relative alla convocazione vanno stabilite dagli organismi sportivi. La sentenza si basa sul fatto che tali organismi dispongono delle competenze e dellesperienza necessarie per espletare questi compiti al meglio. Si nota come la Corte di Giustizia, dunque, mostra sempre di più una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno sportivo, proprio al fine di tenere conto delle sue caratteristiche specifiche tra cui rientra anche lidea stessa di autonomia (perlomeno per tutto ciò che concerne gli aspetti tecnico- sportivi). È innegabile, tuttavia, che, complice anche il fatto che la sentenza Bosman ha avuto ad oggetto la regolamentazione del massimo organo di governo del calcio professionistico europeo in un momento storico nel quale lindustria calcistica europea era in forte crescita anche grazie allavvento delle televisioni a pagamento, tale pronuncia è stata percepita dal settore sportivo come una vera e propria minaccia alla stessa autonomia dellordinamento. Tale periodo si identifica con la sentenza della Corte di giustizia nel caso Meca Medina e Majcen e segna la definitiva negazione delle c.d. regole puramente sportive. In base a tale pronuncia, infatti, tutte le regole emanate dallordinamento sportivo, qualunque sia il loro contenuto, se riferite ad unattività sportiva che riveste i tratti dellattività economica, devono ritenersi soggette ai principi sul mercato interno e sulla concorrenza. Ciò significa che, in caso di effetti restrittivi di una regola sportiva su una delle libertà fondamentali riconosciute dal diritto europeo, tale regola non incorrerà nei rigori del divieto soltanto qualora possa essere giustificata in considerazione degli obiettivi legittimi perseguiti, della sua idoneità a raggiungere tali obiettivi e dal carattere proporzionato della misura rispetto agli obiettivi perseguiti. Sulla stessa scorta del processo di trasformazione ed evoluzione che ha attraversato lUnione Europea, lazione comunitaria in materia sportiva ha conosciuto un significativo periodo di sviluppo che ha portato alla dichiarazione dellAnno Europeo delleducazione attraverso lo sport 2004 e sulla scia delle esperienze maturate in conformità agli obbiettivi ivi espressi, alla emanazione del Libro Bianco sullo Sport (2007). A tal proposito, risulta necessario richiamare un altro documento normativo comunitario che contiene, rilevanti riferimenti allambito sportivo, ovvero il Trattato di Lisbona, sottoscritto nel 2007 da tutti gli Stati membri dellUnione Europea, con cui viene riconosciuto, anche formalmente, lo sport, quale materia oggetto di unautonoma disciplina. Successivamente al Trattato di Lisbona, infatti, il capo III del Trattato istitutivo della Comunità europea diventa il titolo IX la cui denominazione viene modificata con laggiunta in coda del termine sport dopo istruzione, formazione professionale e gioventù. Altresì, lart. 165 (ex art. 149 del Trattato Ce) statuisce che lUnione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa e che lazione della Comunità è intesa tra gli altri scopi, a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo limparzialità e lapertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport proteggendo lintegrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. Con la pronuncia della Corte di Giustizia del 1° luglio 2008 nel caso Motoe, che con riferimento alla questione dellidoneità del potere, ai fini dellorganizzazione delle gare motociclistiche, sottolinea che un sistema di concorrenza non falsata, come quello previsto dal Trattato, può essere garantito solo se sono garantite pari opportunità tra i vari operatori economici. Affidare ad una persona giuridica come lELPA (club automobilistico e turistico che in Grecia rappresenta la Fim, cioè federation international de motocyclism), che, essa stessa, organizza e sfrutta commercialmente gare motociclistiche, il compito di fornire allamministrazione competente un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dellorganizzazione di tali gare, equivale de facto a conferirle il potere di designare i soggetti autorizzati ad organizzare le suddette gare nonché a fissare le condizioni in cui le stesse si svolgono, concedendo in tal modo allente in questione un evidente vantaggio sui concorrenti. Una prerogativa siffatta può indurre limpresa che ne dispone a impedire laccesso degli altri operatori sul mercato di cui trattasi. Tale situazione di disparità tra le condizioni di concorrenza è, inoltre, sottolineata dal fatto, confermato alludienza dinanzi alla Corte, che lELPA, quando organizza o partecipa allorganizzazione di gare motociclistiche, non è tenuta ad ottenere alcun parere conforme affinché lamministrazione competente le conceda lautorizzazione richiesta. Inoltre, prosegue la Corte di Giustizia, la stessa assenza di limiti, obblighi o controlli allesercizio del potere di emettere il parere conforme può indurre la persona giuridica incaricata di emettere tale parere conforme a falsare la concorrenza favorendo le gare che essa organizza o quelle alla cui organizzazione partecipa. Successivamente il Giudice comunitario, nonché la Commissione europea, hanno affrontato il tema della compatibilità con i principi in materia di libera concorrenza delle disposizioni dellInternational Skating Union (ISU), in base alle quali la partecipazione ad una competizione sportiva non autorizzata dallISU comportava per i partecipanti la definitiva impossibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate dallISU (quali, le Olimpiadi invernali, i Campionati del mondo, i Campionati europei, ecc.). Dopo aver espressamente richiamato la giurisprudenza Motoe, il Tribunale ha ritenuto le norme ISU incompatibili con lart. 101 TFUE in quanto: il potere di autorizzare le competizioni organizzate da altri soggetti era sostanzialmente rimesso allarbitrio dellISU, posto che non erano indicati in modo chiaro e preciso i requisiti in presenza dei quali lautorizzazione poteva essere concessa; le sanzioni previste in caso di partecipazione a competizioni non autorizzate dallISU erano manifestamente eccessive e sproporzionate; in nessun caso la legittimità degli obiettivi perseguiti dallISU con la propria regolamentazione (vale a dire, la tutela dellintegrità dello sport dalla minaccia che le scommesse sportive potessero generare rischi di manipolazione delle competizioni e degli atleti) poteva giustificare il carattere sproporzionato delle misure. Infine, con il più recente caso Superlega, la giustizia comunitaria ha delineato un chiaro indirizzo delle politiche comunitarie sul rapporto tra Unione europea e fenomeno sportivo. Invero la Superlega era nata come competizione calcistica europea, la prima al di fuori del cerchio di influenza UEFA, destinata a svolgersi con cadenza annuale tra club di altissimo livello: nel progetto iniziale, i partecipanti sarebbero stati essere venti, di cui quindici ammessi di diritto e cinque ammessi sulla base dei risultati sportivi conseguiti nella stagione precedente. In nessun caso, inoltre, la partecipazione alla Superlega avrebbe impedito ai club di continuare a partecipare regolarmente ai rispettivi campionati nazionali o europei. Occorre anche sottolineare che, da un punto di vista organizzativo e di governance, la nuova competizione risulta di proprietà esclusiva di una società a responsabilità limitata di diritto spagnolo (la European Superleague Company, S.L., ESLC), capogruppo di tre distinte società.La FIFA e la UEFA, in reazione a tale circostanza hanno rilasciato una dichiarazione con la quale hanno manifestato il loro rifiuto di riconoscere listituzione della Superlega; hanno avvisato dellespulsione di qualunque giocatore o club che partecipasse a tale competizione da quelle organizzate dalla FIFA e dalle confederazioni regionali; hanno espresso il principio che tutte le competizioni devono essere organizzate o riconosciute dallorganismo interessato;Tale comunicato è stato confermato da una nuova dichiarazione del 18 aprile 2021 rilasciata dalla UEFA, dalla Federazione calcistica dellInghilterra e dalla Premier League, dalla Reale Federazione Spagnola di Calcio, da La Liga, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega Serie A nella quale vi è un nuovo, chiaro avvertimento circa ladozione di misure disciplinari nei confronti di quei club e calciatori che avessero partecipato alla creazione della Superlega; contestualmente, veniva annunciata espressamente lesclusione dei club da qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europea o mondiale e la privazione per i loro giocatori dellopportunità di rappresentare le loro squadre nazionali; LAssociazione Europea delle Leghe Professionistiche di Calcio ha pubblicato un comunicato di sostegno unanime alla dichiarazione della FIFA e della UEFA al fine di coordinare le misure necessarie per impedire lavvio della nuova competizione e per adottare le misure disciplinari annunciate dalla FIFA e dalla UEFA nei confronti di quei club e calciatori partecipanti alla nuova competizione; A livello nazionale, per quanto riguarda lItalia, il 26 aprile 2021 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato lart. 16 delle proprie Norme organizzative interne (NOIF) stabilendo che ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla FIGC è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la autorizzazione della FIGC comporta la decadenza della affiliazione. In seguito a dette dichiarazioni, chiaramente volte a determinare il fallimento del progetto Superlega, la ESLC ha avviato davanti al Tribunale di commercio di Madrid unazione giudiziaria contro UEFA e FIFA finalizzata, da un lato, ad accertare nel merito che le condotte dellUEFA e della FIFA costituiscono comportamenti restrittivi della concorrenza ai sensi degli artt. 101 e/o 102 TFUE; e, dallaltro lato, ed in via cautelare, ad ottenere la cessazione immediata di tali condotte illegittime e il divieto della loro futura reiterazione. Lo stesso Tribunale rinvia la questione alla Corte di Giustizia europea per accertare se sussistano violazioni degli artt. 101 e 102 TFUE. Tale circostanza, tuttavia, non appare risolutiva ai fini del ben più vasto e complesso tema della compatibilità del modello organizzativo della Superlega con il diritto dellUnione Europea. Con il rinvio pregiudiziale del Giudice spagnolo alla Corte di Giustizia europea, la stessa ha sostenuto che fosse esistente un conflitto con i Trattati dellUnione Europea, che si intenderebbero violati, per abuso di una posizione dominante, ovvero per lesione di diritti garantiti dai trattati stessi, come il diritto di concorrenza. Alla luce di questo breve excursus giurisprudenziale, appare abbastanza chiaro che i quesiti pregiudiziali sollevati dal giudice spagnolo non attengono al tema della compatibilità con il diritto dellUnione Europea della Superlega; né, tantomeno, al principio di una sola federazione per sport e allassociato ruolo delle Federazioni sportive di regolatori unici, nellinteresse della uniforme pratica dellattività sportiva. Al contrario, questi ultimi riguardano il ben più limitato e circoscritto aspetto della legittimità con il diritto UE del sistema di previa autorizzazione della FIFA e dellUEFA per lorganizzazione di eventi sportivi ad opera di soggetti terzi diversi dalle Federazioni stesse1. Ancora, con lultima recentissima pronuncia del Tribunale di Madrid sulla questione, che si uniforma allindirizzo della Corte di Giustizia, risulta chiaro che il calcio europeo, dopo la sentenza Bosman ha dovuto prendere atto delle mutate circostanze e adattarsi alle stesse, anche a costo di una profonda trasformazione delle sue basi sociali e culturali, nello stesso modo la vicenda della Superlega ha svelato drammaticamente la necessità di una non più rinviabile riconsiderazione complessiva della struttura organizzativa e di governo del calcio professionistico europeo. Sotto il versante normativo, inoltre, sebbene alcuni principi e regole possano indicare la strada da seguire, le peculiarità del caso Superlega, unitamente alle inevitabili implicazioni politiche, sociali e culturali, rendono impossibile qualsiasi riferimento alla giurisprudenza pregressa, svelando il limiti dellapproccio case-by-case teorizzato dalla sentenza Meca Medina e Majcen. Avv. Sofia Savagnone